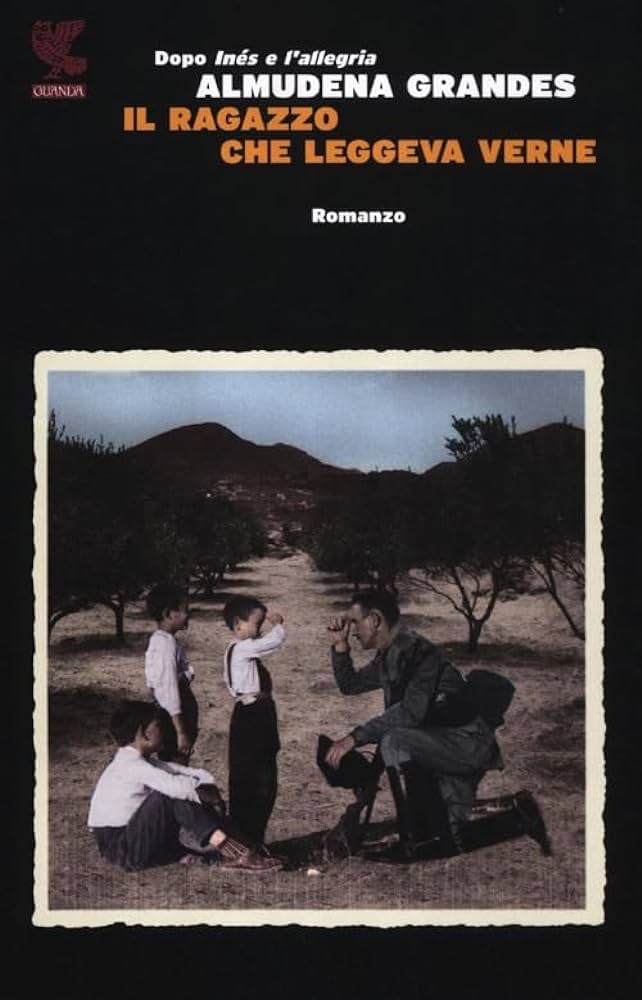Roma conosce nei primi decenni del ‘900 un certo sviluppo artistico. Anche se non si può certo paragonare ad altre capitali europee, come Parigi o Londra, ha tuttavia circoli artistici, esposizioni e luoghi di ritrovo, frequentati da personalità artistiche di rilievo. Le donne artiste trovano propri spazi, anche se con fatica. Particolare la storia di Pasquarosa Marcelli.

Pasquarosa Marcelli nasce in una famiglia contadina ad Anticoli Corrado, nel 1896. Questo paese della valle dell’Aniene è conosciuto dagli artisti per la bellezza del paesaggio e per il fascino delle donne, che vengono ricercate come modelle per gli studi di via Margutta o per l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Nel 1912, a 16 anni, Pasquarosa si reca a Roma dalla zia Maria Lucantoni, che dopo una carriera come modella ha sposato uno scultore svizzero.
Anche lei posa per diversi artisti e conosce il pittore romano Umberto Natale Bertoletti, per cui posa e con cui inizia una relazione sentimentale, osteggiata dalla famiglia benestante di lui. Lui le fa da maestro, la incoraggia a istruirsi, le dà in mano tavolozza e pennelli, scoprendo il suo talento. Pasquarosa inizia a frequentare i pittori della capitale e a dipingere, esordendo alla III Esposizione Internazionale d’arte della Secessione Romana con cinque dipinti. Il termine Secessione indica un movimento artistico, che intende opporsi all’arte ufficiale e accademica.
I suoi lavori ottengono apprezzamenti dalla critica ufficiale e vengono acquistati da personaggi illustri, come la regina Margherita, che ne sceglie uno raffigurante una natura morta (questo quadro, Fiori, si trova attualmente al Palazzo del Quirinale).
Nel 1915 Pasquarosa sposa con rito civile il Bertoletti e i due vanno ad abitare in una casa procurata loro da Luigi Pirandello, con cui hanno un rapporto di stima e amicizia. Nel 1916 nasce il primo figlio, Giorgio.
Sempre nel 1916 la pittrice espone alla IV Esposizione Internazionale d’arte della Secessione romana. Un quadro viene comprato dal Comune di Roma e oggi si trova presso la Galleria comunale d’Arte Moderna e Contemporanea.
Partecipa al Gruppo moderno italiano, che raccoglie artisti vicini al postimpressionismo, contrari alle sperimentazioni. Il termine postimpressionismo indica un movimento artistico nato come reazione al naturalismo degli impressionisti, con la ricerca di maggiore essenzialità di forme e colori. Si cerca inoltre di rappresentare il mondo secondo la sensibilità personale dell’artista, staccandosi sempre più da una rappresentazione realistica dello stesso. La pittura di Pasquarosa è attenta, rigorosa e geometrica.
Durante la prima guerra mondiale il marito è al fronte, ma le scrive e la incoraggia a proseguire la carriera artistica e lei dipinge ed espone.
Negli anni ’20 i due coniugi frequentano Giorgio De Chirico, interessato al loro lavoro.
Nel 1923 Pasquarosa è presente in mostre organizzate da gallerie private.
Nel 1924 nasce il secondo figlio, Carlo Francesco.
Nel 1925, in compagnia del marito, si reca a Torino, Parigi, Madrid, per visitare musei ed esposizioni.
Nel 1927 partecipa a due eventi importanti: XCIII Esposizione degli Amatori e Cultori e alla Mostra d’Arte del Lyceum.
Nel 1927 sposa il Bertoletti con rito religioso e poco dopo partecipa alla II Mostra d’Arte Marinara.
In questa occasione il quadro intitolato Capanne sulla spiaggia (detto anche Cabine o Portoferraio) viene acquistato dal Comune di Roma. Il dipinto, oggi presso la Galleria comunale di Arte moderna e contemporanea di Roma, rappresenta la maturazione raggiunta dalla pittrice in questi anni, sia per l’accurata ricerca tonale di colori freddi, ma luminosi, sia per l’aspetto quasi metafisico delle solitarie e silenziose cabine sulla spiaggia deserta.
Incomincia una presenza anche all’estero: nel 1928 a Madrid e nel 1929 a Londra, con nature morte, composizioni floreali e vedute di Roma. La mostra personale alla Arlington Gallery di Londra è qualcosa di insolito e straordinario per un’artista italiana dell’epoca.
Il successo la porta a esporre in molte occasioni importanti, come la Quadriennale di Roma o la Mostra d’Arte Femminile, sempre nella capitale.
Gli anni della seconda guerra mondiale comportano un rallentamento della sua attività e frequenti soggiorni ad Anticoli Corrado.
Nel 1953 vince il premio Marzotto di Valdagno, per la pittura.
Nel dopoguerra riprende intensamente a esporre. Partecipa alle Biennali di Venezia, alle Quadriennali romane e ha diverse personali in gallerie di Roma. La sua pittura diventa più sciolta, con tonalità luminose, colori pastello.
Muore a Camaiore, in Versilia, nel 1973.
Se non occupa un posto nella storia dell’arte, è pur vero che Pasquarosa è stata invitata a tutte le rassegne nazionali del suo tempo e tutti i critici autorevoli l’hanno menzionata nelle riviste specializzate. Arriva a Roma da analfabeta e muore leggendo Shakespeare. È stata definita “un fenomeno dell’arte”.
Nel 2021, a Villa Pignatelli, a Napoli, sono stati presentati suoi lavori, insieme a quelli delle artiste Claire Fontaine e Marinella Senatore.